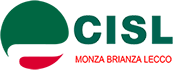Analizzando i dati riportati nel Bollettino delle Entrate Tributarie 2024, pubblicato lo scorso marzo, si evince che le imposte dirette (Irpef su tutte) sono versate in prevalenza da pensionati e dipendenti, che coprono oltre il 55% del totale. Raffrontate al totale delle entrate, le imposte dirette costituiscono il 57% del totale. (https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/entrate_tributarie_2024/Bollettino-entrate-Dicembre2024.pdf)
Nell’analisi ministeriale dei dati IRPEF per il 2023, condotta dalla Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali del Dipartimento delle Finanze, risulta che i redditi di pensionati e dipendenti si attestano attorno agli 862 miliardi di euro (rispettivamente 308 e 554), ovvero a circa l’81% dei redditi in totale dichiarati. Parliamo di una platea di oltre 36 milioni di persone, con un reddito medio che si attesta all’incirca a 24.000 euro annui. (https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?search_class%5b0%5d=cCOMUNE&opendata=yes)
“Di fronte a questi dati – commenta Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza Brianza Lecco – è assolutamente ragionevole asserire che l’intero sistema tributario italiano è sostenuto per la gran parte da pensionati e dipendenti, pubblici e privati. Giusto per fare chiarezza: non sono rodomontate costruite ad arte e millantate a fini di ‘bottega’, bensì affermazioni ben radicate nella realtà dei fatti”.
Ancora un bagno di realtà targato ISTAT, ovvero la cosiddetta ‘economia non osservata’, che unisce economia sommersa e illegale. (https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/Report-ECONOMIA-NON-OSSERVATA-NEI-CONTI-NAZIONALI_ANNO2023.pdf) Nel primo caso le principali componenti sono costituite dal valore aggiunto occultato tramite comunicazioni intenzionalmente errate del fatturato e/o dei costi (sotto-dichiarazione) o generato attraverso l’impiego di lavoro irregolare. La stima ISTAT indica un ‘nero’ che veleggia tra i 3,5 e oltre i 4 milioni di unità, valutando ad esempio le dichiarazioni degli autonomi, che superano i 4,5 milioni, chissà come pressoché integralmente orientate al minimo. L’economia illegale include la produzione di beni e servizi proibita da norme, o se lecita, svolta da operatori non autorizzati.
Ebbene, nel 2023 il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, si è attestato a 217,5 miliardi di euro, con una crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente (quando era 202,4 miliardi). L’incidenza dell’economia non osservata sul Pil, cresciuto a prezzi correnti del 7,2%, è lievemente aumentata al 10,2%, dal 10,1% del 2022.
“Insieme all’impegno su tutti i tavoli contrattuali per rilanciare in primis l’ineludibile questione degli incrementi salariali – continua Scaccabarozzi – la Cisl è da sempre coinvolta nel contrasto all’evasione, al lavoro nero e alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico e nelle istituzioni, consapevole e convinta di doversi impegnare senza tregua contro la cruda realtà di uno sfruttamento che calpesta la dignità e i diritti fondamentali delle persone anche qui, nel nostro territorio. Basterebbe una rapida ricognizione dei nostri Uffici vertenze per verificare in diretta che non ci siamo affatto ‘dimenticati’ di nero e illegalità”.
Ma la difesa dei diritti del lavoro fa il paio, per la CISL, con il sostegno all’ipotesi di una pensione di garanzia per i più giovani – in particolare per le donne, che soffrono anche di un consistente gap retributivo – le cui carriere lavorative sono non solo segmentate ma in molti casi letteralmente polverizzate. “A chi ci accusa di voler condurre politiche di retroguardia, alimentando richieste di integrazione contributiva da parte dello Stato, il cui unico esito sarebbe la crescita improduttiva del debito pubblico, rispondiamo che stanti i numeri sopra ricordati, anche solo ridurre di un terzo la soglia di evasione consentirebbe di garantire contribuzioni figurative che coprano i periodi di discontinuità lavorativa, la disoccupazione involontaria non coperta da Naspi, i periodi di riqualificazione e formazione e, infine ma non ultimo, anche il lavoro di cura famigliare e prestato ai congiunti non autosufficienti” sottolinea il Segretario Generale UST. “Si può pensare a un meccanismo capace di stabilire una soglia minima di garanzia da incrementare in proporzione al numero degli anni lavorati e l’istituzione dell’obbligatorietà della previdenza complementare, che almeno in parte ridurrebbe il rischio di future generazioni che, dopo essere magari passate dal limbo del lavoro povero, lo cesserebbero per precipitare nell’inferno di una pensione povera”.