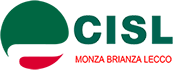In vista delle elezioni del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo, vi proponiamo l’intervento integrale di Pier Paolo Baretta, già segretario generale aggiunto della Cisl, parlamentare, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, vicepresidente Enpaia, tenuto a Torino nell’incontro Europa e lavoro: quali prospettive?, organizzata dalla Fai Cisl.
Il dibattito sulla globalizzazione è stato segnato, soprattutto in Europa, dal confronto/scontro tra quattro diverse interpretazioni.
Quella liberista, che ha avuto maggior successo, che ha considerato la globalizzazione come un fenomeno solo positivo, che avrebbe assicurato sviluppo e crescita per tutti. In particolare per quelle Nazioni e popoli che erano tagliati fuori dai flussi produttivi e commerciali. Questa tesi si basa sul presupposto che la crescita, come la marea, avrebbe alzato tutte le barche.
Il motore di questo meccanismo è il mercato libero, il più libero possibile, e uno Stato minimo. Lo strumento: una tassazione piatta, la flat tax, unica e uguale per tutti, secondo un principio di uguaglianza – siamo tutti nella stessa barca, per l’appunto – che prevede di fare… «parti uguali tra diseguali».
Questa linea ha influenzato Governi e le grandi Organizzazioni internazionali; in particolare il Fmi e la Banca Mondiale, che hanno finito per legittimare, in nome del progresso mondiale, la diffusione delle ingiustizie.
L’altro movimento culturale e politico, che ha aggregato il radicalismo di sinistra ed ambientalista più estremo, ha visto la globalizzazione come un fenomeno solo negativo: incubatore di squilibri e disuguaglianze, soprattutto a causa dello sfruttamento intensivo di risorse naturali ed umane da parte dei grandi oligopoli internazionali, sostenuti e controllati dalla grande finanza.
Ribellarsi a questa logica ha significato teorizzare un modello economico totalmente alternativo al mercato e al capitalismo. Si tratta della «decrescita felice». Sottovalutando che la lotta alle disuguaglianze, dalla quale muovono i contestatori, si coniuga con la crescita – equa e sostenibile – perché senza crescita non c’è redistribuzione e nella decrescita possono sopravvivere solo coloro che più hanno accumulato.
La socialdemocrazia, che, però, si è piegata su se stessa perché la tesi che le pecore (i capitalisti) vanno tosate per distribuire la lana, ha cozzato contro la tesi sbagliata economicamente, ma politicamente vincente, che ci sarebbe stata lana per tutti.
In più, diciamo la verità, è stata ammaliata dalla teoria della marea e dalla idea di magnifiche sorti e progressive.
Il movimento ambientalista (che per primo aveva visto il punto vero del problema) si è rinchiuso in una visione troppo settoriale e, spesso, è stato fagocitato dal radicalismo, perdendo di vista la questione decisiva della crescita.
Le grandi battaglie sindacali hanno fatto la loro parte, ma le difficoltà sono evidenti: una visione troppo localistica e protezionista; rappresentanza tradizionale degli insider.
Il capitalismo renano in alternativa a quello anglosassone; la economia sociale di mercato; la dottrina sociale della Chiesa e, più recentemente, l’economia del dono e l’economia circolare, sono tuttora valide teorie ed esperimenti e vanno ascoltate e incoraggiate.
Ma è mancata una strategia politica compiuta in grado di affrontare e risolvere il problema strutturale che la globalizzazione ci ha posto, ovvero lo squilibrio tra la limitatezza della offerta e l’ampliamento della domanda.
Opportunità e squilibri globali
Quello, infatti, che è successo, nella realtà economica e sociale è che con la fine dell’isolamento economico di milioni di persone (la Cina, l’India, il Bangladesh, l’Africa e parte dell’America Latina) e con il loro ingresso nel sistema capitalistico e nella economia di mercato, si è, effettivamente, prodotto un innalzamento relativo, molto relativo, ma decisivo, delle loro condizioni di vita e di reddito. Il che ha comportato la riduzione della povertà assoluta.
Ma, al tempo stesso, si è determinata una distribuzione della ricchezza (reddito e patrimonio) squilibrata, che ha allargato la forbice tra i più poveri e i più ricchi: il 20% più ricco (di cui noi facciamo parte) controlla il 72% del patrimonio mondiale e il 60% più povero solo il 12,4%.
Disuguaglianze intollerabili; non solo tra i diversi popoli, ma dentro gli stessi popoli, le stesse nazioni, le stesse comunità.
La recente e rapida concentrazione della maggioranza della popolazione mondiale nelle città (già il 55%, ma che arriverà al 75% nel 2045; in Europa siamo già a questa percentuale) ha aumentato a dismisura la necessità di beni e servizi (case, fognature, acquedotto, scuole, sanità e trasporti), ai quali non si è fatto fronte adeguatamente, dando vita a periferie sempre più estese e sempre più degradate economicamente e moralmente. Periferie materiali ed esistenziali: dalle favelas a Torre Maura.
Inoltre la crescita della popolazione mondiale (si arriverà a 9 miliardi nel 2050), che è già in atto, provocherà un aumento della domanda di cibo del 50% e dell’acqua del 40%. C’è, dunque, più gente nella casa comune, ma non ci sono posti a tavola per tutti.
Col paradosso che con lo spreco della filiera alimentare e i rifiuti di cibo che vengono gettati, si potrebbero sfamare il miliardo di persone senza cibo e i 48 milioni di europei che non riescono a mangiare ogni giorno.
Se poi pensiamo che il solo scarto alimentare produce 24,6 milioni di CO2 e la plastica sta consumando i mari e le riserve ittiche, è fin troppo chiaro che stiamo logorando la casa comune.
Al tempo stesso questa crescita demografica non è omogenea. Un solo esempio. L’età media in Italia (tra le prime del mondo) è di quasi 83 anni, in Nigeria è di 54,5. Ma, in Nigeria le nascite sono di 5,32 figli per donna, mentre in Italia sono scese a 1,38 figli per donna (il tasso di ricambio è collocato a 2,1). Assistiamo, come in tutto l’Occidente, a quello che Francesco ha definito un: «inverno demografico».
Dunque i Paesi ricchi invecchiano e i Paesi poveri esplodono. Il risultato è anche un inarrestabile movimento di persone (si stima un miliardo di migranti). Non c’è muro o filo spinato che tenga, ma solo regolazione dei flussi e integrazione.
La marea, infatti, quando arriva, non alza tutte le barche, ma solo quelle già in grado di navigare; quelle con delle magagne, da riparare, vanno a fondo.
Se poi, invece della regolare marea arrivano mareggiate, alternate a delle secche straordinarie – come è successo con la crisi del 2008, smentendo i teorici della crescita infinita – solo le barche che godevano di un buon cantiere alle spalle, di una costante manutenzione, cioè di mezzi e risorse, o che sono riuscite a innovare scafo e strumentazione, si sono salvate. Le altre no.
Per questo cambiano le priorità, sia per i «cattivi», che per i «buoni»: cibo, acqua, energia, consumo di suolo, ambiente, sono le nuove emergenze che giustificano le nuove guerre. L’economia, la tecnologia, il controllo dei mercati sono le vere armi del secolo XXI.
La posta in gioco non è un trono di… spade, ma di grano, di cereali, di aria, di… «vetro di drago», direbbero Daeneris Targaryen e Jon Snow, noi lo chiamiamo «silicio». Dietro la guerra dei dazi, che stanno combattendo Usa e Cina, c’è il controllo delle tecnologie innovative (5G) e del gas; in Libia e in Venezuela c’è il petrolio.
Quale Europa
Che fare, allora? Che strada prendere? Innanzitutto occuparci di una nuova governance mondiale. Chi parla più dell’Onu, del Wto, dell’Ilo? Il Fondo monetario compare talvolta nelle cronache mondane per l’eleganza di Christine Lagarde e, prima, per le avventure erotiche di Strauss Kahn; la Banca mondiale è praticamente scomparsa.
Certo con i guai che sono stati combinati qualcuno potrebbe dire che non se ne sente la mancanza. Invece, la assenza di una governance mondiale è un serio problema.
Come sta, in proposito, il sindacalismo internazionale ed europeo? Quali sforzi si stanno facendo per farlo diventare un soggetto centrale nella definizione delle nuove regole del gioco?
Non spetta più a me dare risposte, se non dire che una strada consiste nell’assumere la Agenda 2030 delle Nazioni unite e il programma Europa 2020 come la piattaforma del nostro quotidiano agire politico e sindacale.
Nel percorrere questa strada l’Europa può e deve essere protagonista.
Lo può perché è stata, e, per molti versi è ancora, artefice di un modello politico, economico, sociale e culturale che, nato nella seconda metà del secolo scorso, per affrancarsi dall’orrore di due guerre e delle dittature nazista e fascista, ha dato vita ad una società libera, democratica, multiculturale, solidale.
Questo modello è parte della identità europea e, sia pure logorato e da riformare, appare, sempre più, il solo in grado di dare una risposta equilibrata agli scompensi della globalizzazione e un futuro ai cittadini europei.
È quando abbiamo deviato da questo modello che ci siamo persi, interrompendo il rapporto tra i cittadini e l’Europa. Rapporto che si è logorato a causa di 3 fattori.
Politico – Un allargamento disordinato dell’Unione Europea che, in assenza di regole comunitarie su fiscalità e welfare, ha provocato una competizione al ribasso sui costi e le protezioni sociali.
Economico – Una visione rigorista dei vincoli di bilancio. Ricordo il dibattito sul pareggio di bilancio. Sia chiaro il pareggio, o meglio «l’equilibrio» (come recita l’art. 81 della nostra Costituzione) di bilancio è un valore. Ma deve tenere conto del ciclo condomino favorevole o avverso. In tal senso si colloca la idea di esonerare gli investimenti per la crescita dai vincoli del bilancio e introdurre una assicurazione europea contro i picchi di disoccupazione. Ciò ha prodotto una disattenzione eccessiva ai bisogni locali e ai destini delle comunità.
Gestionale – I principali dossier sono affidati a una tecnocrazia europea competente, ma spesso miope e troppo burocraticamente invadente.
Perché è accaduto ciò? Principalmente perché, anziché procedere verso gli Stati Uniti d’Europa (prospettiva che era apparsa del tutto evidente, almeno dopo i trattati di Maastricht e Lisbona e Schengen e soprattutto con la caduta del muro e la unificazione delle due Germania) gli Stati membri hanno fatto troppo spesso prevalere, per interessi particolari, il gioco esasperato dei veti incrociati e del peso del più forte, offuscando gli interessi comunitari.
È successo per i flussi migratori; per le politiche di sviluppo; per la gestione del debito; per le controversie sulle politiche industriali e commerciali; per l’assenza di una comune politica estera, in primis verso la Russia. Sergio Fabbrini dice: «Se l’Ue avesse avuto le risorse e gli strumenti per gestire la crisi finanzia e migratoria, quel dissenso non si sarebbe espresse in termini favorevoli ai sovranisti».
E chi è stato responsabile di queste mancate scelte? La troppa Europa o il troppo nazionalismo?
Sicché, contrariamente alle tesi dei nazionalisti, che sostengono che l’Europa è malata di obesità, ovvero di eccesso di Europa, possiamo sostenere che la sua vera malattia è l’anoressia, ovvero una carenza di Europa.
Tutto ciò ha provocato la percezione sempre più diffusa tra i suoi cittadini che l’Europa è lontana, matrigna, inerte.
Eppure, ecco il punto, nonostante ciò, l’Europa è, nel panorama globale, un luogo privilegiato per vivere e per lavorare.
Perché ci ha offerto e offre grandi, incontestabili, opportunità: la pace, la convivenza pacifica, l’euro, la stabilità, la libera circolazione delle persone.
Perché è depositaria del principale patrimonio storico, artistico e culturale (che la rende sempre più meta di visitatori).
Perché è il primo mercato mondiale, produttore e consumatore di beni che esporta ed importa in e da tutto il mondo. È il partner primario di 80 Stati (gli Usa solo di 20). Le importazioni in Europa dai Paesi in via di sviluppo superano, da sole, quelle di Usa, Giappone e Canada riunite.
E, infine, il «costo della non Europa» è calcolato in un abbattimento del 12% del Pil europeo.
Per noi il danno sarebbe incalcolabile. L’Italia detiene il più importante brand del mondo: il Made in Italy (come sapete bene voi che ne fate parte); siamo il primo Paese al mondo per patrimonio artistico e secondo paese manifatturiero d’Europa, dove vanno il 66% delle nostre esportazioni.
Data la nostra naturale posizione geografica nel mediterraneo, godiamo di una potenzialità logistica straordinaria; i porti aperti non portano solo migranti, ma anche turisti (oltre 216 milioni nel 2018) e merci.
Pensiamo, davvero, che tanto vantaggio competitivo sia compatibile, nel mondo globale, con una visione autarchica?
Ci sono voluti pochi mesi perché la Gran Bretagna si rendesse conto di quanto fosse scriteriata un’idea di questo tipo e poche settimane perché Salvini abbia ricevuto, proprio sui migranti e il debito, il benservito dai suoi amici nazionalisti.
La verità è che per essere veri nazionalisti (ovvero, avere a cuore gli interessi nazionali) conviene essere europei.
Quale modello sociale europeo
Ma, soprattutto perché questi risultati sono stati ottenuti per merito di un modello di sviluppo retto da una economia sociale di mercato, dallo Stato sociale, di forme di democrazia economica.
Sappiamo che questo modello non è omogeneo e molto differenziato tra Stato e Stato.
Possiamo individuare almeno tre modelli principali di welfare.
Il modello nordico e centro europeo: alte tasse, alta protezione, alte opportunità di lavoro; quello anglosassone: meno tasse, meno welfare; quello mediterraneo (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), che ha una buona protezione pubblica, ma minori tassi di crescita ed occupazione e fa molto affidamento sul sostegno familiare.
È interessante osservare come i Paesi con le migliori performance di crescita economica e delle tecnologie informatiche e della comunicazioni sono anche quelli nei quali si è maggiormente sviluppato il Welfare State (mercato del lavoro, istruzione, pensioni).
Ciò che, però, al di là di queste differenze, ci consente di parlare di modello sociale europeo è che al fondo c’è un idea comune che prevede uno Stato attivo, interventista in economia; con un diffuso sistema di protezione sociale per tutti, ma a partire dai più vulnerabili; rispettoso della persona e dei suoi diritti, contro le disuguaglianze. Obiettivi da raggiungere anche col coinvolgimento attivo dalle «parti sociali».
I dati a sostegno del modello sociale europeo sono chiari: pur avendo il 7% della popolazione mondiale, in Europa si spende la metà della spesa sociale globale. Quasi il 30% del Pil europeo va in spesa sociale. Nel 2017 sono stati spesi circa 2.890 miliardi per la protezione sociale.
I sussidi per la disoccupazione si attestano nei Paesi dell’Unione europea intorno al 50%, mentre negli Stati Uniti è il 27%, in Russia il 21% e in Cina il 14%.
In Europa ci sono 1,7 incidenti sul lavoro ogni 100.000 lavoratori, con un’incidenza maggiore nei Paesi dell’Europa orientale. Negli Stati Uniti sono 3,4, in Russia 6 e in Cina 9,4 per mille.
Se si pensa che Il 61% dei cittadini europei individua proprio nella protezione sociale l’obiettivo principale di un’Europa più giusta e vicina ai propri bisogni, capiamo quanto ciò sia importante.
Tutto bene, dunque? No. Proprio queste percentuali ci dicono quanto lavoro c’è ancora da fare. A cominciare da una riflessione sul modello stesso, la cui crisi è sotto gli occhi di tutti a causa sia degli errori sopraesposti, sia per gli effetti della globalizzazione.
Come rilanciare, allora, il modello sociale europeo nell’epoca globale?
Quando, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale fu affidato a William Beveridge il compito di disegnare lo Stato sociale, egli si concentrò sulle emergenze di allora: ignoranza, miseria (lo «squallore», lo definì!), bisogno, ozio, malattia.
Oggi questi temi restano fondamentali, ma dobbiamo andare oltre. Verso temi come la formazione e la conoscenza (i 2/3 delle assunzioni nella economia della conoscenza sono posti di lavoro qualificati); il benessere e il tempo libero; la salute e gli stili di vita, la cittadinanza attiva e la partecipazione sociale ed economica.
Ciò comporta una nuova visione dei sistemi economici e di protezione. A partire dell’affrontare le principali criticità del modello sociale. Ne elenco 4:
La nuova organizzazione internazionale del lavoro. Che prevede la delocalizzazione delle produzioni nei paesi emergenti, che comporta pesanti processi di ristrutturazione, disoccupazione, precarietà del lavoro e di aumento della povertà; ma anche la necessità di scegliere dove sviluppare le nostre capacità.
In un ambiente senza confini e che cambia continuamente e rapidamente è necessaria una buona capacità di adattamento di resilienza, delle persone e delle comunità. Pensate solo alle trasformazioni del mondo agricolo e agroalimentare.
Serve una politica di sviluppo europea che, pur nell’ambito di una ovvia competizione, anche tra europei, individui i settori chiave sui quali costruire una strategia comune. Ma, soprattutto alla innovazione.
Gli squilibri demografici. L’invecchiamento della popolazione (83 anni medi in Europa di attesa di vita) e la caduta della natalità, comportano una trasformazione della composizione sociale, della struttura familiare, con più famiglie monoparentali ed una urgente gestione dei flussi migratori e della conseguente integrazione.
La questione ambientale e la tutela del creato. A partire dalla vivibilità dei territori. In questa ottica dobbiamo rafforzare il welfare decentrato a livello locale per cogliere meglio quelle specificità che la globalizzazione, fortunatamente, non è in grado di annientare. Infatti, una governance a più livelli è inevitabile.
La partecipazione politica e la democrazia economica. La nuova struttura dei bisogni e dei consumi che accompagna la nascita di nuove forme di individualismo, con la riduzione del peso dei sindacati e la crescita del potere dei consumatori, necessitano di nuove forme di democrazia e di partecipazione.
La democrazia economica è, dunque, la giusta prospettiva per il futuro del sistema sociale europeo.
Un nuovo protagonismo sociale
Di fronte a questi snodi lo Stato sociale del futuro non può essere solo… lo Stato. Nel welfare tradizionale lo Stato si fa completamente carico del rischio. Sicurezza sociale ha significato assenza o riduzione del rischio personale.
Ma, in una situazione nella quale la domanda di welfare è destinata ad aumentare, se non altro per le dinamiche demografiche e i processi di ristrutturazione e riconversione, di cui abbiamo parlato, e gli Stati sono più esposti ai problemi del debito pubblico, il rischio è che lo Stato non riesca a far fronte a tutta la domanda.
Se, allora, non vogliamo abbandonare o depotenziare lo Stato sociale, dobbiamo condividerne i destini. In tal senso, l’assunzione di parte del rischio, o, se preferite, la assunzione di responsabilità, in un’ottica di sussidiarietà, può anche essere un fattore di stimolo, di miglioramento, di crescita, dentro regole comunemente definite. Non ho bisogno in questa sede di rimarcare l’importanza della logica negoziale, del contratto; non solo quello del lavoro, ma in generale come sistema di relazioni trasparenti.
A sostegno di questa impostazione serve una fiscalità europea equilibrata e di scopo.
Dobbiamo comunque assicurare la gratuità integrale delle prestazioni in specifiche situazioni: maternità e malattie gravi ed invalidanti; disoccupazione in età avanzata ed infortuni da lavoro; ma, dobbiamo intensificare di più le forme di assistenza integrativa privata a carattere contributivo, ovviamente meglio se contrattuale.
Dobbiamo difendere la progressività dell’imposta, come mezzo per limitare le disuguaglianze e favorire lo spostamento generalizzato dalla tassazione dal lavoro ai consumi e, pur sapendo quanto sia difficile, dovremo riformare le tax expenditur.
La protezione sociale, dunque, non va affatto abbandonata, ma ripensata alla luce di queste priorità.
Infine, per riuscirci davvero, serve anche una prospettiva politica. Ma di questo ne parliamo dopo le elezioni europee.